Ultimi dell'anno: tempo di tirare le somme prima del conto alla rovescia. Giudizio Universale si sottrae al gioco ritrito dei voti e delle pagelle finali e va a scovare per voi tutte quello che le top ten - di critica o di vendita - non vi raccontano
di Dario De Marco

Illustrazione di Elide Gramegna
Le classifiche di fine anno sono un genere tanto vituperato quanto intramontabile: e fa ridere che ad averle mutuate dai vecchi giornali cartacei (matusa!), traghettandole nel mondo duepuntozero siano stati proprio i ggiovani e iconoclasti blogger, che il giornalismo tradizionale si propongono di abbattere, a colpi di post e retweet.
Per cui noi, che non siamo né l'uno né l'altro, evitiamo di propinarvi il best-of, e semplicemente approfittiamo di un periodo in cui la fame aumenta (sia per cercare idee regalo-rattoppo che per riempire l'i-pod) proponendovi come già in passato un excursus tra i generi “fuori classifica”. Jazz, etnica, e roba ancora più strana: per ognuna di queste tre categorie, ecco due dischi, che in comune hanno anche qualcos'altro. Buon ascolto.

Come conciliare la ciclicità minimalista degli accordi di De André con le variazioni armoniche vitali per l'improvvisazione jazz? I capolavori del cantautore genovese traggono forza proprio dalla semplicità estrema dei giri: non è la banalità delle canzonette pop italiche, ma il rigore implacabile della musica popolare. Danilo Rea, eccellente pianista che già altre volte ha tradotto in jazz i nostri cantautori, interpreta De André in piano solo.
E qui la sfida si fa impossibile: perché De André e jazz sono proprio agli antipodi, sicché, fino a quando il piano di Rea si aggira nei dintorni dell'originale, il pezzo rimane De André e non riesce a decollare; appena parte per la tangente si fa subito jazz, e non è più De André. Lo ammette implicitamente lo stesso pianista quando ricorre a delle introduzioni tanto affascinanti quanto completamente avulse dalla canzone che segue (Valzer per un amore, La canzone di Marinella, Carlo Martello). E anche se non mancano momenti toccanti come Ave Maria o entusiasmanti come Girotondo, in conclusione due bellezze - l'opera di Faber e il magico tocco di Rea – non ne producono una terza. E la missione impossibile è compiuta solo in parte.

Come conciliare la torrenziale furia improvvisativa del free jazz con le atmosfere rarefatte tipiche del marchio Ecm? Qui abbiamo da un lato uno dei monumenti dell'avanguardia totale, il settantenne Roscoe Mitchell, sassofonista e vero animatore di quell'Art Ensemble of Chicago che ebbe nel trombettista Lester Bowie il suo volto più noto. Dall'altro c'è l'ormai mitica casa discografica di Manfred Eicher, nota per aver messo all'opera tutti i grandissimi del jazz contemporaneo, assoggettandoli alla propria poetica, fatta di suoni sussurrati al limite del silenzio, di melodie brumose, di distillati nordici.
Niente di più distante, sembrerebbe. E invece alla Note Factory di Mitchell - un doppio quartetto che ricorderebbe quello dell'album fondativo del genere, l'eponimo Free jazz di Ornette Coleman del 1960, se non fosse per la presenza ingombrante di due pianoforti - il miracolo riesce: ed è proprio nella perfetta fusione dei due opposti. Soprattutto nella lunga suite iniziale (Far side/Cards/Far side) quello che si ascolta è una sorta di stupefacente free al ralenti, l'esplosione di una rabbia fredda, controllata. Missione compiuta quindi.

L'oriente visto dall'occidente, ovvero un ponte tra Italia e Iran. Nato e residente qui, il Navà ensemble è un gruppo misto, composto da tre musicisti iraniani (Pejman Tadayon alla voce e ai liuti tradizionali, Reza Mohsenipoor anche lui agli strumenti a corda e Hamid Mohsenipoor ai tamburi tipici) e due italiani, ovviamente con una solidissima preparazione (Martina Pelosi che canta e Paolo Modugno alle percussioni).
Musica persiana rivisitata: non vi aspettate facili contaminazioni o indoramenti di pillola in stile world, però neanche una roba pallosa o per specialisti. Infatti la musica persiana è già di per sé un continuo scambio tra la tradizione classica - che come da noi si è sviluppata nei secoli scorsi presso le corti, a opera di compositori che ne hanno codificato le regole - e la tradizione popolare - a differenza che da noi ancora molto viva e in evoluzione; anzi le tradizioni popolari, dato che numerose sono le etnie di quel grande paese. I pezzi del disco pescano un po' qua e un po' là: non sono riproposizioni dei brani classici né riprese filologiche dei pezzi popolari, ma composizioni autonome che si ispirano a entrambi i filoni, e che spesso mettono in musica poesie di grandi autori come Omar Khayyam e Jalal-ad-Din Rumi.
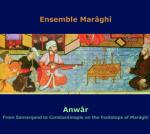
Musica sull'antica Via della seta. Il nume tutelare cui il gruppo ha dedicato il proprio nome è Abd ul-Qadir Maraghi (1360-1435): nato in Persia, vissuto tra Samarcanda e Baghdad, morto nell'afghana Herat. Non si fatica a immaginarlo per quello che fu: suonatore, compositore, teorico che sistematizzò la grande tradizione musicale pan-islamica.
All'altro capo della Via della seta, c'è Venezia, città natale dell'ensemble: infatti anche in questo caso a far rivivere questi suoni ci sono musicisti italiani, anzi stavolta sono tutti italiani (Giovanni De Zorzi al flauto ney, Giovanni Tufano al liuto arabo oud, Francesco Clera alle percussioni zarb e bendir) anche se pure qui con anni di apprendistato, e con la benedizione finale della magnifica voce di Sepideh Raissadat, ospite d'onore nel disco. Il viaggio spazio-temporale è d'obbligo: e infatti Anwar inizia con un affascinante excursus nei ritmi e sentimenti della musica persiana; l'ultimo brano è registato dal vivo al veneziano Fondaco dei Turchi, per secoli il terminal dei traffici e della cultura orientale in Europa.
Poi si passa alla musica ottomana: qui filo conduttore è la cerimonia sufi dei dervisci rotanti, con il tipico crescendo da atmosfere solenni a pezzi più movimentati, fino all'ipnotico tumulto finale. Interpretazioni più rigorose e filologicamente corrette, ma sempre godibili - anzi, consigliate - per l'orecchio dell'occidente.

Il tedesco Micus è un vero sperimentatore, nel senso letterale del termine: proprio come gli scienziati in laboratorio infatti, lui fa degli esperimenti con le cose, per vedere che tipo di suono ne può ricavare. Nella sua carriera discografica, iniziata trentacinque anni fa, uno dei punti più alti è The music of stones (1989) in cui per l'appunto si metteva a soffiare nelle pietre.
In questo disco agisce di preferenza sempre con il fiato (ma non solo), seguendo tendenzialmente questa procedura: prende dei flauti tradizionali in via di estinzione, non contento e cambia la struttura, non contento li sovraincide più e più volte. Per esempio il raj npailm, una specie di oboe di bambù tipico della minoranza Hmong del Laos, viene modificato portando i buchi da cinque a nove, e inserito in armonizzazioni appositamente scritte per farne suonare fino a otto insieme.
Ovviamente la ricerca sul campo, prima di arrivare in laboratorio, presuppone vari e approfonditi giri per il mondo: però che la musica di Micus è una via di mezzo tra classica, new age e world, lo può dire solo chi si rifugia nelle etichette, e magari non ha mai ascoltato un'armonica a bocca giapponese composta da diciassette canne che duetta con un'arpa africana e un coro che canta in una lingua inventata per l'occasione. Capito il motivo del nostro titolo, adesso?

Che cosa lega Sergej Ejzenstejn e i Tuxedomoon? Quanti gradi di separazione ci sono tra il regista russo, ormai ricordato solo per l'aulica definizione che Fantozzi diede del suo La corazzata Potemkin, e il gruppo che a cavallo tra i ’70 e gli ’80 dimostrò che anche negli Stati Uniti c’era spazio per l’art rock, il progressive, le sperimentazioni elettroniche? Adesso uno solo: Que viva Mexico!, colonna sonora di una pellicola incompiuta degli anni ’30, a opera del gruppo messicano Nine rain, guidato dal fondatore dei Tuxedomoon Steven Brown.
Un caleidoscopico viaggio musicale: dalla perfetta fusione di rock ed etnica a momenti più tipicamente da soundtrack, da classici pezzi in stile Tuxedomoon a tipici ritmi messicani in tre quarti, da brani dove il free si mescola con l’elettronica, o il progressive con il minimalismo. Come Steven Brown, fuggito dagli Usa nei terribili anni '80 e animatore di questo gruppo misto, anche Ejzenstejn si era innamorato del Messico, dove aveva girato materiale per un documentario epico e collettivo, senza poterne finire il montaggio: da allora circolano varie ipotesi, varie versioni del film.
Insomma, di che stiamo parlando? Del leader in esilio di un gruppo che non c'è più, che si è ispirato a un film che non c'è mai stato, incidendo un disco che voi probabilmente nei negozi non troverete. Allora, state ancora a chiedervi perché questa sezione l'abbiamo intitolata così?
Tags: Anwar, Bold as light, Chicago Art Ensemble, Danilo Rea, Dario De Marco, ecm, Ensemble Maraghi, etnica, Fabrizio De Andrè, fine anno, Hilat, jazz, Navà Ensemble, Nine Rain, Que Viva mexico Sergej Ejzestejn, recensione, Roscoe Mitchell, Stephan Micus, Tuxedomoon. classifiche,












Commenti
Invia nuovo commento