Verso il lontano oriente, nella fantasia o nel tempo, a trovare i vecchi amici degli anni della scuola. Anche d'estate vedere un film significa soprattutto viaggiare: e con i nostri consigli non servono nemmeno le sale aperte
di Marinella Doriguzzi Bozzo e Andrea B. Previtera
AMICHEVOLE: Per ricordare i compagni di un tempo e per apprezzare quelli di oggi
Le ragioni dell'aragosta di Sabina Guzzanti, Italia, 2007, 100 m

Lo spettacolo da montare è un percorso in fieri, che riprende in modo anche critico gli sketch di un tempo, tra crisi, ricordi, analisi psicologiche, sfottò. Alternando credibilmente attualità satirica, voce ironica fuori campo, spezzoni d'epoca televisivi e non - la marcia dei 40mila Fiat - riunioni più o meno alcoliche, complotti di persuasione o dissuasione dove ognuno conosce bene i punti deboli degli altri.
Con un bell’apologo finale, in cui anche i giullari, come tutti, devono solo andare avanti, al di là del disgusto e della consapevolezza della crescente inutilità della satira, ma con la fierezza di non mettersi mai a servire i padroni. Una sorpresa più che positiva, meno invadente e supponente di Viva Zapatero (2005), a dimostrazione del fatto che talvolta - anche se per poco tempo, se si potesse - invecchiare puo’ fare bene. A modo suo una sorta di Grande freddo meno ad effetto ma più salvifico, perchè sostenuto dall’deologia di allora, dalla rivisitazione della medesima, e dalla fatica di lavorare e vivere.
 “Tratto da una storia vera”. Assolutamente falso – non troverete la dicitura virgolettata né nei titoli di coda né tanto meno sulla locandina. Eppure verissimo. Compagni di Scuola è un contenitore di luoghi comuni e figure retoriche magistralmente coordinate in un balletto di due ore, per la regia di un Carlo Verdone più se stesso che mai. Tra le fila delle ombre dei liceali di un tempo (condensate nelle controfigure del presente per un ritrovo “vent’anni dopo”) ci sono proprio tutti: l’intellettuale logorroico, il timido buono e malaticcio, il maneggione e l’eterno innamorato, la femme fatale e la dottoressina, il duo goliardico, il belloccio sfiorito e il grassottello con rivincita.
“Tratto da una storia vera”. Assolutamente falso – non troverete la dicitura virgolettata né nei titoli di coda né tanto meno sulla locandina. Eppure verissimo. Compagni di Scuola è un contenitore di luoghi comuni e figure retoriche magistralmente coordinate in un balletto di due ore, per la regia di un Carlo Verdone più se stesso che mai. Tra le fila delle ombre dei liceali di un tempo (condensate nelle controfigure del presente per un ritrovo “vent’anni dopo”) ci sono proprio tutti: l’intellettuale logorroico, il timido buono e malaticcio, il maneggione e l’eterno innamorato, la femme fatale e la dottoressina, il duo goliardico, il belloccio sfiorito e il grassottello con rivincita.Ma soprattutto c’è lui – quel personaggio incolore seduto in una fila senza numero, compagno di se stesso davanti a un banco vuoto. Dal pomeriggio all’alba del giorno dopo, in una villa di campagna si sciolgono i nodi di una vita solo per crearne di nuovi e si consumano tutte quelle tragedie rimaste sospese come uno starnuto trattenuto a forza: a lungo termine inevitabili. Forse l’apice dell’esperienza dietro la macchina da presa, per Verdone, che non sbaglia un tempo o un viraggio di tono mentre si destreggia con i temi della memoria, della rivalsa, della perdita, della crescita - muovendo i fili di un parterre attoriale che raccoglie la maggior parte dei talenti di cinema e teatro fine anni ottanta. Meravigliosamente amaro.
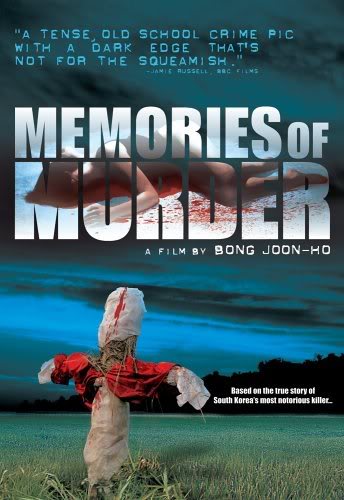 In una scassata stazioncina di polizia di campagna, tre smandrappati agenti, stolidi, opportunisti e violenti, si arrabattano impotenti intorno all’omicidio di una giovane donna. Vengono raggiunti da un poliziotto esterno, professionale e naturalmente subito odiato. E gli omicidi si sprecano. Tratto da un passo di cronaca vera, il miracolo di questo film sta nella naturalezza con cui una sceneggiatura perfetta e molto composita, unita ad un abile quanto naturale modo di usare la cinepresa, riesce a stratificare gli eventi e a stipare la narrazione senza che si possa far la minima obiezione alla presunta veridicità del racconto: che sembra scorrere malgrado lo spettatore, anche quello più scafato. Mentre il plot si dipana, il gruppo degli uomini cambia, quasi invertendo caratteri e ruoli. Sì che il serial killer non inciderà soltanto sulla traiettoria umana delle vittime, ma anche su quella dei poliziotti. Esempio interessante di come una cultura “altra” da quella occidentale affronti un tema classico, senza farne né un giallo né un thriller. (A tal proposito, per comprendere meglio una civiltà diversa dalla nostra, basterebbe confrontare The departed di Scorsese con Infernal affairs del cantonese Lau, che Scorsese ha copiato parola per parola, ma con risultati assolutamente inapparentabili all’originale: più povero, più imperfetto, ma infinitamente più affascinante).
In una scassata stazioncina di polizia di campagna, tre smandrappati agenti, stolidi, opportunisti e violenti, si arrabattano impotenti intorno all’omicidio di una giovane donna. Vengono raggiunti da un poliziotto esterno, professionale e naturalmente subito odiato. E gli omicidi si sprecano. Tratto da un passo di cronaca vera, il miracolo di questo film sta nella naturalezza con cui una sceneggiatura perfetta e molto composita, unita ad un abile quanto naturale modo di usare la cinepresa, riesce a stratificare gli eventi e a stipare la narrazione senza che si possa far la minima obiezione alla presunta veridicità del racconto: che sembra scorrere malgrado lo spettatore, anche quello più scafato. Mentre il plot si dipana, il gruppo degli uomini cambia, quasi invertendo caratteri e ruoli. Sì che il serial killer non inciderà soltanto sulla traiettoria umana delle vittime, ma anche su quella dei poliziotti. Esempio interessante di come una cultura “altra” da quella occidentale affronti un tema classico, senza farne né un giallo né un thriller. (A tal proposito, per comprendere meglio una civiltà diversa dalla nostra, basterebbe confrontare The departed di Scorsese con Infernal affairs del cantonese Lau, che Scorsese ha copiato parola per parola, ma con risultati assolutamente inapparentabili all’originale: più povero, più imperfetto, ma infinitamente più affascinante).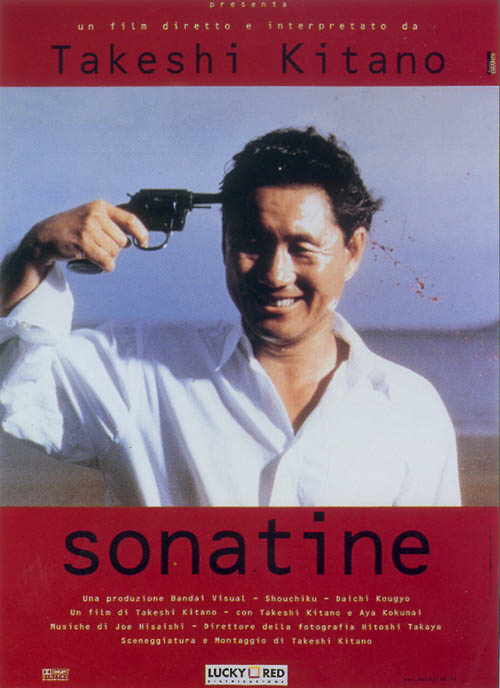 Murakawa è un uomo di mezza età stanco e disincantato, che ha perso interesse nella routine del proprio lavoro: lo Yakuza di medio livello. Un’ultima operazione prima di ritirarsi, una missione diplomatica per portare la pace tra due fazioni rivali. E dunque, da una cupa Tokyo notturna di locali fumosi, prostitute e armi da fuoco - ai cieli tersi dell’estate su Okinawa, tra camicie floreali e silenziose spiagge deserte.
Murakawa è un uomo di mezza età stanco e disincantato, che ha perso interesse nella routine del proprio lavoro: lo Yakuza di medio livello. Un’ultima operazione prima di ritirarsi, una missione diplomatica per portare la pace tra due fazioni rivali. E dunque, da una cupa Tokyo notturna di locali fumosi, prostitute e armi da fuoco - ai cieli tersi dell’estate su Okinawa, tra camicie floreali e silenziose spiagge deserte.Kitano introduce personaggi privi di forma, ognuno uguale a mille altri nello schema immutabile dell’onore e dell’obbedienza: poi ne scopre l’animo nascosto, li dipinge con cura e incanto già sapendo di doverli uccidere uno dopo l’altro senza troppe cerimonie.
Un capolavoro dalla poesia impalpabile nascosta appena un centimetro sotto la qualità video da VHS di second’ordine, un montaggio quasi dilettantesco, la totale assenza di fotografia. Tenero e struggente.
 I film sulla e nella scuola sono moltissimi, da Maddalena zero in condotta a La classe, da Grease a L’attimo fuggente, da La scuola a If, da Another country fino all’esperimento 'nazista' de L'onda (2008). E si potrebbe continuare per più paragrafi. Ma, fra tutti, questo è quello più spiazzante, più commovente, più coinvolgente, più intelligente.
I film sulla e nella scuola sono moltissimi, da Maddalena zero in condotta a La classe, da Grease a L’attimo fuggente, da La scuola a If, da Another country fino all’esperimento 'nazista' de L'onda (2008). E si potrebbe continuare per più paragrafi. Ma, fra tutti, questo è quello più spiazzante, più commovente, più coinvolgente, più intelligente. In una zona di provincia inglese, una scuola anonima si ripromette di portare a Cambridge o a Oxford il proprio gruppetto di maturandi più brillanti. Senza sapere bene perché, ognuno fa proprio questo traguardo, dagli insegnanti agli allievi, che sono posti qui su di uno stesso piano di indagine e resi complici prima dall’intelligenza, poi dalla cultura e dall’obiettivo comune. Modalità che rendono lo spettatore da subito consapevole - e nostalgico - delle proprie possibilità scolastiche mancate.
E se il sapere - alto - si mischia a tutta una serie di osservazioni e considerazioni agite sulle modalità didattiche, prepotenti emergono i caratteri dei singoli e dei loro rapporti. Le tematiche variano dal serio al burlesco, allo scottante e al drammatico. Insieme alla capacità di dare un’impronta umana e al tempo stesso intellettuale all’intera vicenda, emerge la sapienza nel trattare tematiche delicate come la sessualità - compresa quella "deviante" - in maniera leggera e, al tempo stesso, quasi violenta.
Bravissimi gli interpreti, ottima la sceneggiatura, funzionale ed essenziale la regia che non ricorre a figure carismatiche alla Robin Williams in L'attimo fuggente, ma rimane con i piedi per terra. Del resto, la vicenda è tratta dall'omonima commedia teatrale di quel finissimo scrittore che è Alan Bennett. Unico escamotage, l’ambientazione nei primi anni '80 - perchè oggi il tutto, anche parlando di élites, sembrerebbe fantascienza. Anche se non sa bene finire, rincorrendo diverse suggestioni, questo è un film che non si dimentica più. Se i giovanissimi e gli insegnanti d’oggi lo vedessero - e lo capissero - potrebbero spararsi. E noi con loro.
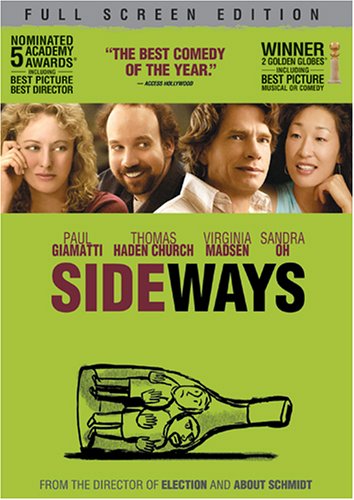 Che cosa ci fa vivere? Probabilmente solo la traiettoria propulsiva dovuta all’esser stati generati, fino alla morte, ma neanche in linea retta: obliquamente, di sghembo. Nel frattempo, con i nostri caratteri, mangiamo, beviamo, dormiamo, amiamo o crediamo d’amare per amicizia o per amore, obbedendo meccanicisticamente a quella spinta inerziale che ci sforziamo di considerare unica e quindi densa di significati - e in realtà pietosamente uguale per tutti. E se per caso delle differenze sopravvenissero, ci affrettiamo ad annullarle, copiando gli altri per non sentire il freddo dell’essere diversi e quindi - qui sta il paradosso - temporaneamente “significanti”.
Che cosa ci fa vivere? Probabilmente solo la traiettoria propulsiva dovuta all’esser stati generati, fino alla morte, ma neanche in linea retta: obliquamente, di sghembo. Nel frattempo, con i nostri caratteri, mangiamo, beviamo, dormiamo, amiamo o crediamo d’amare per amicizia o per amore, obbedendo meccanicisticamente a quella spinta inerziale che ci sforziamo di considerare unica e quindi densa di significati - e in realtà pietosamente uguale per tutti. E se per caso delle differenze sopravvenissero, ci affrettiamo ad annullarle, copiando gli altri per non sentire il freddo dell’essere diversi e quindi - qui sta il paradosso - temporaneamente “significanti”. Tutto questo detto in tono leggero, aggraziato, ma incisivo, sotto la metafora di una settimana di vacanza fra due amici. Uno aspirante scrittore frustrato nel lavoro e nei sentimenti (che sfoga la rigidità della sua visione esistenziale nella passione per il vino) l’altro alla vigilia di un matrimonio importante, cui tenta di sfuggire: da un lato aggrappandosi all’evento, dall’altro cogliendone tutto quello che può, in una specie di rito inziatico alle prossime rinunce monogamiche.
 Si può essere giovani e basta, visto che la condizione comprende una manciata di anni, come numeri asettici? Forse sì, se in qualche modo si è già individui. Meno, se si appartiene ad una comunità che identifica la giovinezza come una categoria sostitutiva delle nostre individualità. E qui Van Sant mette a segno il primo goal, focalizzando la propria attenzione su un gruppo di skaters, all’interno di un anonimo liceo di sottofondo. Skaters che hanno il loro credo nella fisicità e la loro iniziazione virile riassunta e reiterata nella sfida alla gravità.
Si può essere giovani e basta, visto che la condizione comprende una manciata di anni, come numeri asettici? Forse sì, se in qualche modo si è già individui. Meno, se si appartiene ad una comunità che identifica la giovinezza come una categoria sostitutiva delle nostre individualità. E qui Van Sant mette a segno il primo goal, focalizzando la propria attenzione su un gruppo di skaters, all’interno di un anonimo liceo di sottofondo. Skaters che hanno il loro credo nella fisicità e la loro iniziazione virile riassunta e reiterata nella sfida alla gravità. E un Luogo di riferimento, mitico e subdolo, mal frequentato e pericoloso: Paranoid Park. Qui, in una sera qualsiasi, nemmeno brava ma solo deprivata, il sedicenne Alex uccide una guardia giurata per un malaugurato incidente. E decide di far finta di niente, essendo provvisto di un precario bagaglio affettivo: un amico in fondo solo di tavola, un padre tatuato e assente, una madre querula e remissiva, un fratellino che gli racconta storie televisive ormai incomprensibili per un adolescente, una ragazza che vuole solo scoparlo e che non gli piace abbastanza.
Allora, di colpo, tutta quella giovinezza che sembra anche negli altri solo un turgore di superficie, annidato svagatamente in corpi nuovi e in capelli ed epidermidi in rodaggio, implode. E la leggerezza che ha contraddistinto i giorni anonimi e noiosi, diventa un peso, anzi un contrappeso al modesto sogno di Icaro della tavola da skate, dostoievskianamente anche corpo del reato.
Così Alex affronta il proprio percorso di colpa guardandosi dentro per la prima volta e scrivendo proprio i dettagli della notte che aveva cercato di rimuovere, in un anelito di prosecuzione della normalità e di disconoscimento della coscienza. Girato a Portland in super 8, il film alterna un modo di girare acuminato e iperrealista a momenti sgranati e svagati, al rallentatore, mutuando molte scene più dalla video art che non dal cinema (da cui comunque cita sia i fratelli Cohen - Blood simple - che Fellini). La colonna sonora non ha niente di giovanilistico, ma è tutta giocata sull’accompagnamento di un percorso che in realtà è una forma di stream of consciousness, fino all’accertamento della verità e alla raggiunta liberazione dell’io. Semplice e sorvegliatissimo, sofisticato e ingenuo, anonimo e personalissimo, il film è un acuto saggio sulla giovinezza e ha il merito di rovesciare il concetto di gruppo in favore del singolo, di saper interiorizzare ciò che da tempo è ormai sempre più spesso solo descrizione esteriore.
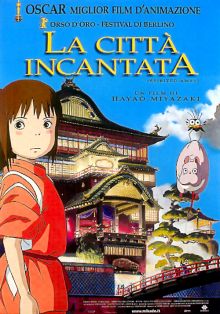 Intrappolata in un mondo fantastico governato dalla strega Yubaba, la piccola Sem cerca di sottrarre i genitori all’incantesimo che li ha trasformati in maiali. Nel suo percorso - che è anche il solito rito d’iniziazione - incontra Haku, che l’aiuta: fra i due nasce l’amore, il miracolo che mette a posto tutte le cose. La storia, contaminata occidentale, è un pretesto per una narrazione visiva senza uguali sia sotto l’aspetto pittorico che sotto il profilo poetico e inventivo: dall’essere senza volto alle teste rotolanti, dal bebè mostruoso agli uccelli di carta, dall’uomo fango alla stessa città con le sue strane terme, il suo treno acquatico e via dicendo.
Intrappolata in un mondo fantastico governato dalla strega Yubaba, la piccola Sem cerca di sottrarre i genitori all’incantesimo che li ha trasformati in maiali. Nel suo percorso - che è anche il solito rito d’iniziazione - incontra Haku, che l’aiuta: fra i due nasce l’amore, il miracolo che mette a posto tutte le cose. La storia, contaminata occidentale, è un pretesto per una narrazione visiva senza uguali sia sotto l’aspetto pittorico che sotto il profilo poetico e inventivo: dall’essere senza volto alle teste rotolanti, dal bebè mostruoso agli uccelli di carta, dall’uomo fango alla stessa città con le sue strane terme, il suo treno acquatico e via dicendo.  Tutto il colore romantico degli scontri ardimentosi tra mercenari dell’aria nei cieli dell’Italia anni 20, per questo lungometraggio animato in cui Miyazaki condensa più che mai i suoi topoi poetici. Perchè Porco Rosso, pilota eccezionale tanto retto quanto burbero, tra un combattimento e il successivo non fa segreto d’essere anarchico e liberale. Disprezza il totalitarismo che sta germinando in Europa (“Meglio Porco che fascista”), e osserva il fermento politico con pigro disinteresse da un’isoletta privata persa nel mar Mediterraneo, da cui si allontana in ugual misura solo per rispondere all’immancabile codice d’onore del Ronin o per darsi al cibo e al buon vino. C’è spazio per una delicata storia di quel tipo d’amore "d’altri tempi", per alcuni combattimenti aerei, ma è tutto qui: questa volta non c’è bisogno di castelli semoventi o città incantate, per un film d’animazione scanzonatamente poetico che non trova necessario neppure spiegare l’accidentale trasformazione di Marco, il protagonista, in un maiale antropomorfo. Una storia senza capo né coda, senza una vera riga di gesso tra buoni e cattivi, priva di morali o insegnamenti di sorta: semplicemente una storia. Splendidamente raccontata.
Tutto il colore romantico degli scontri ardimentosi tra mercenari dell’aria nei cieli dell’Italia anni 20, per questo lungometraggio animato in cui Miyazaki condensa più che mai i suoi topoi poetici. Perchè Porco Rosso, pilota eccezionale tanto retto quanto burbero, tra un combattimento e il successivo non fa segreto d’essere anarchico e liberale. Disprezza il totalitarismo che sta germinando in Europa (“Meglio Porco che fascista”), e osserva il fermento politico con pigro disinteresse da un’isoletta privata persa nel mar Mediterraneo, da cui si allontana in ugual misura solo per rispondere all’immancabile codice d’onore del Ronin o per darsi al cibo e al buon vino. C’è spazio per una delicata storia di quel tipo d’amore "d’altri tempi", per alcuni combattimenti aerei, ma è tutto qui: questa volta non c’è bisogno di castelli semoventi o città incantate, per un film d’animazione scanzonatamente poetico che non trova necessario neppure spiegare l’accidentale trasformazione di Marco, il protagonista, in un maiale antropomorfo. Una storia senza capo né coda, senza una vera riga di gesso tra buoni e cattivi, priva di morali o insegnamenti di sorta: semplicemente una storia. Splendidamente raccontata.  Un film di film, una storia di storie, così come lo è la vita una volta che i giorni passano la soglia indistinta del presente per farsi ricordo. Amarcord, altro non racconta che i frammenti di adolescenza del regista, in una Rimini anni ’30 nebulosa e trasognata. Il ricordo che si fa pellicola, sotto una patina tremula e sfocata – ora dalla nebbia della pianura padana, ora dal polline danzante dell’Estate, dal fumo di sigaretta di un professore di scuola media. E’ un circo onirico in cui si accavallano le vicende di personaggi grotteschi, eppure plausibili, tanti e tali che sembra impossibile figurino tutti sotto un unico titolo. Per gli occhi ancora freschi di vita del regista, la vera Storia è quella delle tirate d’orecchio e dei primi “amori” – con ampie virgolette. La storia del passaggio della Mille Miglia o di un pomeriggio in campagna: il Fascismo fa appena da sfondo, è poco più che qualche ritornello e un paio di buffe marcette. Un gioiello di valore inestimabile per quella setta carbonara di malinconici che sanno riconoscersi con uno sguardo e che quello sguardo tengono sempre per metà sopra la spalla, ricordando, rimpiangendo o anche solo rievocando la bobina già svolta del passato.
Un film di film, una storia di storie, così come lo è la vita una volta che i giorni passano la soglia indistinta del presente per farsi ricordo. Amarcord, altro non racconta che i frammenti di adolescenza del regista, in una Rimini anni ’30 nebulosa e trasognata. Il ricordo che si fa pellicola, sotto una patina tremula e sfocata – ora dalla nebbia della pianura padana, ora dal polline danzante dell’Estate, dal fumo di sigaretta di un professore di scuola media. E’ un circo onirico in cui si accavallano le vicende di personaggi grotteschi, eppure plausibili, tanti e tali che sembra impossibile figurino tutti sotto un unico titolo. Per gli occhi ancora freschi di vita del regista, la vera Storia è quella delle tirate d’orecchio e dei primi “amori” – con ampie virgolette. La storia del passaggio della Mille Miglia o di un pomeriggio in campagna: il Fascismo fa appena da sfondo, è poco più che qualche ritornello e un paio di buffe marcette. Un gioiello di valore inestimabile per quella setta carbonara di malinconici che sanno riconoscersi con uno sguardo e che quello sguardo tengono sempre per metà sopra la spalla, ricordando, rimpiangendo o anche solo rievocando la bobina già svolta del passato. Tags: Andrea B. Previtera, carlo verdone, federico fellini, Gus Van Sant, Hayo Miyazaki, Marinella Doriguzzi Bozzo, Nicholas Hynter, recensione, sabina guzzanti,












Commenti
Invia nuovo commento